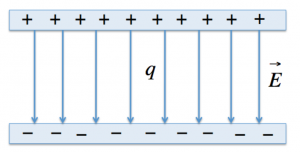Non poteva trovarsi modo migliore di celebrare il decimo anniversario delle stragi dell’11 settembre 2001 della cattura e dell’uccisione del suo ispiratore, Osama bin Laden. La notte di domenica 1 maggio, Barack Obama ha potuto dire “giustizia è fatta”, dopo che una pattuglia dei Navy Seals aveva scovato il leader di Al Qaeda in una villa blindata ad Abbottabad, in Pachistan.
Non poteva trovarsi modo migliore di celebrare il decimo anniversario delle stragi dell’11 settembre 2001 della cattura e dell’uccisione del suo ispiratore, Osama bin Laden. La notte di domenica 1 maggio, Barack Obama ha potuto dire “giustizia è fatta”, dopo che una pattuglia dei Navy Seals aveva scovato il leader di Al Qaeda in una villa blindata ad Abbottabad, in Pachistan.
Il vaticinio di Bush
Non poteva trovarsi modo migliore di celebrare il decimo anniversario delle stragi dell’11 settembre 2001 della cattura e dell’uccisione del suo ispiratore, Osama bin Laden. La notte di domenica 1 maggio, Barack Obama ha potuto dire “giustizia è fatta”, dopo che una pattuglia dei Navy Seals aveva scovato il leader di Al Qaeda in una villa blindata ad Abbottabad, a pochi chilometri dalla capitale pachistana.
La ricerca del colpevole degli attentati alle Torri Gemelle, al Pentagono e all’aereo UA-93 è durata più di dieci anni, perché Osama era già nella lista dei ricercati prima di diventare il re del terrore. Ma le basi della sua cattura furono gettate qualche giorno dopo la strage, quando George Bush, rievocando i vecchi poster del far west, disse “lo vogliano vivo o morto”[1]. Si aprì allora una delle più gradi cacce all’uomo di tutti i tempi, passata attraverso i corpi speciali, la Cia, il Pentagono, i servizi segreti di mezzo mondo, anni di bombardamenti al confine tra Afghanistan e Pakistan, Guantanamo, gli interrogatori ai limiti (e forse anche oltre) della tortura, falsi avvistamenti, delusioni. Fino ad arrivare al biglietto vergato dalla mano di Obama quella notte di maggio di dieci anni dopo: “kill him”.
Il cerchio si è chiuso in perfetta continuità tra i due presidenti, il guerriero e il premio Nobel per la Pace, poiché, come ha detto Obama annunciando la morte di bin Laden, “queste cose sono possibili perché l’America è unica e indivisibile, sotto Dio, con libertà e giustizia per tutti[2]. I presidenti cambiano ma l’America è quella di sempre: Bibbia e Colt.
La caccia è stata lunga ma lo si sapeva sin dall’inizio. Il 20 settembre 2001, George W. Bush si presentò davanti al Congresso riunito in sessione comune per parlare all’America e al mondo, ancora sotto shock per gli attacchi dell’11 settembre. Era passata poco più di settimana dalla distruzione delle Torri Gemelle e il conto definitivo delle vittime era ancora in corso. Ma il presidente degli Stati Uniti, con quella particolare capacità profetica che solo le grandi tragedie sanno generare, vide chiaramente quello che si sarebbe fatto e pensato nel decennio successivo che quest’anno si chiude.
Bush parlò così della “war on terror” che stava per cominciare:
Questa guerra non sarà come quella irachena di un decennio fa, quando liberammo un territorio occupato e giungemmo a una rapida conclusione; neppure somiglierà alla guerra in Kosovo di due anni fa, dove non furono utilizzate truppe di terra e non perdemmo una singola vita americana. Oggi la nostra risposta richiederà molto più di una immediata rappresaglia e attacchi isolati. L’America non deve aspettare una battaglia ma un lunga campagna, diversa da qualsiasi altra abbiamo mai visto. Ci saranno azioni clamorose – di quelle che si vedono in televisione – e operazioni coperte, destinate a rimanere segrete anche nel successo. Affameremo i terroristi tagliando i loro fondi, li metteremo gli uni contro gli altri, li costringeremo a fuggire da un posto all’altro fino a quando non avranno più un rifugio sicuro. […] Scopriremo i piani dei terroristi e li colpiremo prima che possano colpirci. E puniremo le nazioni che aiutano e offrono riparo ai terroristi. Ogni nazione, in ogni parte del mondo avrà una scelta da fare: o siete dalla nostra parte o siete con i terroristi. Da oggi in poi qualunque paese continuerà a offrire protezione e supporto al terrorismo sarà considerato dagli Stati Uniti un regime ostile. Non è solo la nostra guerra, è una guerra che coinvolge il mondo, una guerra di civiltà. È la guerra di chiunque crede nel progresso, nel pluralismo, nella tolleranza e nella libertà. Nel nostro dolore abbiamo intravisto la nostra missione: la libertà e la paura sono in guerra tra loro e il prevalere della libertà – la più grande conquista dei nostri tempi – dipende da noi, dalla nostra generazione [4].
Comincia così il primo decennio del XXI secolo, con una dichiarazione di guerra, tremila vittime sul suolo americano e un mondo che si sveglia dall’illusione della fine della storia. Un decennio che finisce quest’anno e che vede la guerra della libertà contro la paura non ancora conclusasi e la storia che va al galoppo verso direzioni che non conosciamo. Molto di quello che Bush aveva vaticinato è successo e molto deve ancora succedere ma non è troppo presto per chiedersi se siamo arrivati dove volevamo andare o se la strada si sia persa.
Durante la lunga fase della guerra fredda la miscela tra valori e interessi nelle democrazie euro-atlantiche era congelata: i due elementi facevano blocco in nome della difesa del mondo libero. Con il disgelo dell’89 tutto è diventato insieme più difficile e più trasparente: valori e interessi si sono liquefatti e rimescolati in molti modi diversi e soprattutto alla luce del sole, sottoposti cioè ad un vaglio ben più attento ed esigente da parte delle opinioni pubbliche mondiali. Il venir meno della “sfida principale”, e il corrispondente affievolirsi del giustificazionismo ideologico, hanno infatti accelerato enormemente il ritmo del mutamento politico, hanno reso estremamente più ardua la vita dei governi e azzerato la tolleranza da parte degli elettorati verso le pratiche di finanziamento occulto alla politica. Non certo casualmente, dopo l’89 tutti i principali sistemi politici dell’Europa continentale sono stati investiti da crisi di moralizzazione.
Questa stessa dinamica ha investito anche la politica estera in tutti i paesi democratici. Essa è rapidamente uscita dalla dimensione dello stallo per entrare in quella della competizione, sia tra gli alleati di un tempo che tra i vecchi e nuovi avversari. Ma non si è ancora arrivati ad una nuova definizione di regole e di modelli. Così il mondo sembra passare bruscamente da eccessi di multilateralismo a sbalzi unilaterali, da vampate idealistiche a precipitosi ritorni al realismo. Le posizioni in campo, per di più, appaiono intercambiabili: coloro i quali sembrano propendere per soluzioni più idealistiche in una crisi si ritrovano improvvisamente a presidiare la frontiera del realismo integrale in quella successiva e viceversa. E la complessa vicenda che stanno vivendo i paesi arabi in questi ultimi mesi è giunta a confermare – e se è possibile ad amplificare – tale volubilità.
Di fronte a questo scenario apparentemente così contraddittorio, lo scopo che si prefigge quest'articolo è quello di capire se, invece, esiste un filo che lega l’89 e la fine dell’impero sovietico alle rivoluzioni nei regimi dittatoriali del Medio Oriente del 2011, passando attraverso l’11 settembre, la guerra in Afghanistan e in Iraq e l’avvento di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Insomma: questo decennio si apre col vaticinio di Bush ma per comprenderne fino in fondo il senso occorre, insieme, fare un passo indietro e uno in avanti. Dobbiamo gettare il nostro sguardo ai decenni precedenti, a quelli che portarono alla fine della guerra fredda e misero in libertà immense energie compresse che sono state il motore degli anni successivi; e non ritrarci, al tempo stesso, dalla necessità di sporgerci in avanti, verso queste “rivoluzioni arabe” che si dipanano di fronte ai nostri occhi increduli e impreparati e che ci portano verso un futuro insieme entusiasmante e terribilmente rischioso.
Il lascito di Reagan e l'emersione dei neocon
Quando Bush si rivolge al Congresso riunito dal lutto ancora recente parla di una nuova missione per l’America e per il mondo, una missione che si è materializzata tra il fumo della macerie di Ground Zero appena 8 giorni prima: far prevalere la libertà sulla paura, la democrazia sulla tirannide. È probabile che in quel momento chi lo ascoltava non pensasse a una rivoluzione culturale, non avesse ancora sentito parlare dei neo-conservative, nonostante questa minoranza intellettuale fosse attiva da tanti anni, e non attribuisse a quella parola null’altro che un richiamo alla perenne missione etica degli Stati Uniti, la stessa che in principio, in politica estera, aveva assunto le forme dell’idealismo wilsoniano. Ma Bush aveva in mente già allora qualcosa di più e di diverso. In quello stesso discorso il presidente americano traccia una linea di collegamento tra l’ideologia mortifera del radicalismo islamico e le grandi tragedie del totalitarismo del secolo precedente: “Quelli che ci hanno colpito – dice Bush – sono gli eredi delle ideologie assassine del Ventesimo secolo. Seguono il cammino del fascismo, del nazismo e del totalitarismo, ma finiranno il loro cammino allo stesso modo: nella fossa comune delle menzogne della storia” [4].
Bush aveva in mente il suo predecessore, Ronald Reagan, quando – 20 anni prima – davanti alla Camera dei Comuni inglese disse che “la libertà e la democrazia lasceranno il marxismo e il leninismo nella spazzatura della storia” [5]. Era il Reagan combattente per la libertà cui Bush si voleva idealmente ricongiungere, per ricordare quello che egli aveva fatto assieme a Margareth Thatcher e Giovanni Paolo II, per “esportare” libertà e democrazia nell’est Europa post sovietica. È su quella epopea vittoriosa contro the Evil Empire che Bush intendeva innestare la sua nuova guerra contro il “Terrore”. Con l’idea che libertà e democrazia saranno efficaci anche contro la minaccia del radicalismo islamico. Ed è proprio grazie a questo sottostrato culturale ed emotivo che quel gruppo di intellettuali e giornalisti chiamati (polemicamente) neo-conservative ha potuto esercitare una notevole influenza prima sull’amministrazione Bush, poi sul dibattito pubblico americano con effetti che si avvertono fino ad oggi.
Senza i neocons l’intuizione bushiana si sarebbe fermata ad una revisione in chiave vendicativa e difensiva del wilsonismo: una sorta di pax americana imposta al mondo con il pugno di ferro della forza militare anche al fine di tutelare la Patria minacciata. Le idee dei neoconservatori – che il più illustre di loro, Irving Kristol definì “liberal che sono stati assaliti dalla realtà” [6] – si innestano invece efficacemente sulla temperie post traumatica dell’America di allora e forniscono una direzione di marcia quando tutti gli altri sembravano aver perso la bussola. I neocons non vedono l’espansione della democrazia come una missione etica ma come un imperativo dettato dell’interesse nazionale dell’America di creare un contesto stabile e non aggressivo in particolare tra le autocrazie e le dittature medio-orientali. Le democrazie – ragionano i neocons– non hanno bisogno di nemici esterni: sono troppo impegnate a litigare al loro interno. Per le democrazie, dove il peso dell’opinione pubblica si fa sentire, è più difficile scegliere la via della guerra; nelle democrazie si afferma più facilmente il libero mercato, i paesi si aprono al mondo, le merci circolano e i cittadini sostituiscono all’odio e al risentimento la ricerca del benessere e della scalata sociale. Per i neocons la democrazia è un’arma di protezione di massa su cui gli Usa devono investire alla stessa stregua di armamenti e intelligence.
Non c’è nulla di irenistico nell’approccio neoconservatore alla sicurezza nazionale, tutt’altro. Basta guardare alle tesi di quel gruppo di analisti, storici, giornalisti, strateghi che si raccolgono attorno all’American Enterprise Institute, a cominciare da Dick Cheney, da cui Bush prelevò a piene mani per rifornire i ranghi della sua amministrazione. Per tutti costoro la supremazia militare americana rimane il pilastro su cui si fonda la sicurezza del paese: questa va usata senza scrupoli e anche in modo preventivo ogni volta e ovunque si profilino minacce per gli Stati Uniti. La democrazia non è un orpello da donare alle nazioni meritevoli ma un vincolo da “imporre” agli Stati canaglia. E quanto al multilateralismo esso era stato già messo nell’angolo dall’”o con noi o contro di noi” pronunciato da Bush all’indomani dell’11 settembre: nessuno può limitare o anche solo intralciare il diritto degli Usa a difendersi quando è necessario. È la reazione dell’America che, violata sul suo stesso suolo, rafforza e indurisce la sua dimensione statuale come unico strumento efficace e legittimo a garantire sicurezza interna e risposta immediata alle minacce.
L’onda lunga della guerra in Iraq
Il primo documento ufficiale dove questa dottrina comincia ad emergere è il “National Security Strategy of United States” del settembre 2002, un anno dopo gli attentati. È il documento che ogni anno descrive le minacce alla sicurezza del paese e aggiorna le strategie per farvi fronte. Già nelle premesse si legge:
Gli Stati Uniti coglieranno questo momento per estendere i benefici della libertà in tutto il mondo. Ci adopereremo attivamente per portare la democrazia, lo sviluppo, il libero mercato e il libero commercio in ogni angolo del pianeta. Gli eventi dell’11 settembre ci hanno insegnato che stati falliti come l’Afghanistan possono rappresentare un grande pericolo per il nostro interesse nazionale alla pari delle grandi potenze. La povertà non trasforma la gente in terroristi e in assassini, ma la povertà, istituzioni deboli, corruzione possono rendere gli stati vulnerabili alle reti del terrorismo.
E sul diritto al “first strike” non ci sono dubbi:
Le peggiori minacce per l’America derivano dall’incrocio tra radicalismo e tecnologia. In nome del senso comune e della legittima difesa, l’America agirà contro le nuove minacce emergenti prima che queste siano pienamente formate. Non possiamo difendere il paese e i nostri alleati sperando per il meglio. Per questo dobbiamo essere pronti a sconfiggere i piani dei nostri nemici usando la nostra migliore intelligence e procedendo con decisione. La storia giudicherà severamente coloro che vedono il pericolo approssimarsi ma mancheranno di agire. Nel nuovo mondo in cui siamo entrati l’unico strada verso la pace è la strada dell’azione [7].
La guerra in Iraq del 2003 era già contenuta in queste parole.
Ed è forse proprio la guerra irachena, quella avviata senza il sostegno dell’Onu, con la coalizione dei volenterosi che si riconosceva solo nella “strada dell’azione”, quella che Obama ha ereditato “controvoglia” diversamente dell’afghana più corrispondente ai crismi internazionali; proprio la guerra irachena dicevamo, con i suoi orrori, errori e successi può dirci cosa è stato della dottrina Bush e delle idee dei neocon. Può dirci, in particolare, se e cosa di quella visione di politica estera e di difesa è sopravvissuta al decennio successivo all’11 settembre; se il mondo, dopo dieci anni di quella cura, si trovi o no in miglior salute e, soprattutto, se può avere ancora efficacia e utilità anche per gli anni imprevedibili e tumultuosi che si profilano in Medio Oriente e in Nord Africa.
Alla fine del 2010, per iniziativa del National Democratic Institute e con l’esecuzione del centro ricerche Greenberg Quinlan Rosner, è stato pubblicato il più estensivo e accurato sondaggio d’opinione della popolazione irachena sullo stato del loro paese. La ricerca è stata intitolata Iraq’s democracy at a crossroads. Tra ottobre e novembre 2010 sono state realizzate 2000 interviste “faccia a faccia” con cittadini iracheni di diverse aree geografiche e appartenenze etniche. Il quadro che ne esce è molto frastagliato: vi sono forti differenze di percezione sullo stato di salute del paese tra sunniti e sciiti, tra le popolazioni del Nord più ottimista e soddisfatto e quelle della zona occidentale più depressa. Le maggiori preoccupazioni riguardano la mancanza di lavoro, il tasso di corruzione, il costo della vita, la mancanza di alloggi. Ma parametri come la sicurezza, l’educazione, la fornitura d’acqua, la sanità, la condizione della donna, hanno sempre valore positivo. Insomma, l’impressione che se ne trae è quella di un paese normale (con risultati che almeno in astratto non sarebbero diversi in Italia o altrove in Europa) , diviso lungo linee etnico-geografiche, ancora assediato dai lasciti di un regime violento e di una lunga guerra, ma in definitiva capace di riassorbire le tensioni e i problemi con un sistema molto simile a quello che in occidente definiremmo democratico. Significativo in questo senso il dato complessivo emerso da una delle domande cruciali del sondaggio: “Fare dell’Iraq un paese più democratico consentirà migliori servizi e innalzerà la qualità della vita?”. Nel complesso del paese il parere positivo arriva al 61 per cento, quello negativo si ferma al 20, con punte che arrivano al 75 per cento al Sud del paese. Sempre nel complesso il 44 per cento degli iracheni ritiene che il paese sia già una democrazia contro il 35 che ne dubita, ma il giudizio positivo arriva al 58 per cento al Sud e al 65 al Nord.
Sarà anche per questo che le rivolte antiregime che abbiamo visto svolgersi dall’Iran al Marocco passando per l’Arabia Saudita sembrano – almeno fino ad oggi – aver saltato l’Iraq. Certo si registrano caotiche e spesso violente sedute parlamentari, ma su questo punto meglio astenersi da giudizi e confronti!
Quello che oggi può considerarsi accertato è che un Iraq in rivolta, con le popolazioni sciite in piazza contro il predominio di un tiranno sunnita, sarebbe stato un boccone facile e ghiotto per la strategia di espansione regionale di Teheran. Invece, il tassello iracheno mancante fa saltare il puzzle di potere del regime di Ahmadinejad e ne ritarda e ostacola la marcia di conquista.
Certo la guerra irachena è costata molto sangue e molte vittime (quasi 5000 vittime solo tra le forze armate americane e un numero ancora controverso di morti civili, ma sicuramente superiore ai centomila), ci ha mostrato cose che non avremmo mai voluto vedere, come i soprusi di Abu Graib e cose che non dimenticheremo facilmente come i morti italiani di Nassiriya. È una guerra che è stata dichiarata frettolosamente vinta dopo due mesi e che, ancora, non si è davvero conclusa. Ma gli errori attengono più alla conduzione della guerra che non ai principi e ai motivi che l’hanno ispirata. E sono errori che, a ben guardare, non inficiano la teoria e si rivelano particolarmente illuminanti per capire quello che non si dovrebbe ripetere a dieci anni di distanza nelle nuove rivoluzioni arabe.
Le lezioni da non smarrire
Sarebbe qui troppo lungo ripercorre le molti fasi della vicenda irachena, ma in modo sintetico si può dire che all’origine dei molti rovesci e del sanguinoso prolungarsi della guerra ci sono almeno due fattori principali. Il primo risiede senz’altro nella violenta e precipitosa de-baathificazione del paese seguita alla caduta di Saddam, che ha insieme sospinto molta parte della popolazione sunnita verso l’insorgenza e privato l’amministrazione dei quadri superiori che ne garantivano il funzionamento. Il secondo elemento è stato la marcia forzata verso la “democratizzazione”, quando si è tentato di imporre il modello democratico occidentale in un paese in cui mancava ancora la società civile e la dinamica dei partiti era sostituita da scontri settari: come se le transizioni alla democrazia nei paesi dell’ex Unione Sovietica non avessero insegnato nulla!
Sono indicazioni che, questa volta, non devono essere smarrite per essere applicate, ad esempio, all’Egitto di oggi dove le carceri svuotate durante la “rivoluzione di papiri” si stanno di giorno in giorno riempiendo di funzionari e dirigenti pubblici “compromessi” con il regime di Mubarak, lasciando decapitati e nel caos interi ministeri e il settore bancario. Così come le elezioni fissate per settembre sono considerate da molti osservatori troppo precoci e perciò tendenzialmente favorevoli ai Fratelli musulmani, gli unici dotati di organizzazione sul territorio e del canale di propaganda delle moschee.
È la tesi classica di Bernard Lewis:
Chiedere elezioni generali immediate è assurdo. È richiesta una certa maturità ed esperienza da parte di quei popoli, qualità che non si trovano tra gente soggetta alla tirannia da decenni. Se si tengono elezioni premature si dà l’immediato vantaggio ai gruppi di persone che hanno la capacità di manipolare e intimidire. In una probabile elezione, le principali fazioni opposte sarebbero i democratici e i fondamentalisti religiosi. Questi ultimi hanno tre immensi vantaggi nelle elezioni libere: in primo luogo fruiscono di una formidabile rete di comunicazione e incontro costituita dalle moschee. Neppure il più dittatoriale dei regimi è mai stato in grado di controllare i pulpiti della predicazione. Il secondo vantaggio è che i fondamentalisti parlano un linguaggio familiare, usano termini islamici direttamente comprensibili per le masse, al contrario del linguaggio dei diritti umani e civili e della libertà, che spesso ha persino bisogno di parole nuove o importate. Il terzo vantaggio, poi, è che i partiti democratici sono per loro natura costretti a permettere la libera propaganda dei loro avversari. I fondamentalisti non incorrono in questo “handicap”, al contrario essi ritengono un dovere sopprimere quei partiti che considerano empi e atei. È l’approccio fondamentalista alla democrazia: un uomo, un voto, una volta soltanto [8].
Non c’è, insomma, una estraneità genetica tra il mondo arabo e islamico e la democrazia ed evocare il caso iraniano o quello delle elezioni a Gaza per sostenere questa tesi è sbagliato. La democrazia – o la libertà, cui Lewis preferisce riferirsi – possono essere potenti elementi di stabilità e di pace anche in Medio Oriente, se non si pretende di farvi attecchire il già compiuto modello occidentale senza passaggi intermedi.
Se le cose stanno così, e se davvero il bilancio decennale della dottrina Bush e delle teorie neoconservatrici è tutt’altro che quella catastrofe che gli anni obamiani hanno voluto far credere, viene da chiedersi come mai davanti agli eventi che sconvolgono il mondo arabo in questi mesi, il fronte repubblicano e anche quello neocon sembra sospettoso o, quanto meno, diviso sul da farsi. Mentre i Democratici, che sull’Afghanistan e l’Iraq erano dubbiosi e recalcitranti, oggi sembrano predicare, almeno in Libia, l’esportazione della democrazia a suon di Tomahawk.
La risposta al secondo quesito è forse più semplice: il motivo lo ha spiegato molto bene Ross Douthat sul “New York Times”:
La guerra in Libia sembra uscita dal libro d’oro dell’interventismo liberal. Obama ha mostrato una squisita deferenza verso ogni istituzione internazionale e governo straniero che Bush aveva ignorato o scavalcato. La guerra è stata benedetta dall’Onu, appoggiata dalla Lega Araba, spinta dai diplomatici di Hillary Clinton molto più che dai militari di Robert Gates. Il suo scopo umanitario è molto più chiaro delle sue connessioni con la sicurezza nazionale americana ed è stata iniziata non dalla marina e dall’aviazione Usa ma dalla Francia [9].
I dubbi repubblicani si spiegano di riflesso, e almeno in parte, con queste stesse motivazioni. La guerra in Libia è una guerra sostenuta dalla grande stampa liberal americana, molto popolare presso l’opinione pubblica affascinata dall’afflato di libertà che sembra sgorgare dai ribelli del regime gheddafiano, sostenuta con insolito zelo da paesi e leader europei un tempo critici verso le guerre bushiane. Dal punto di vista repubblicano queste sono basi troppo volatili per impegnare l’America in una nuova avventura militare lontana dagli orizzonti strategici nazionali. E soprattutto è un intervento che consente a Obama di fare ciò che gli riesce meglio: “il guerriero riluttante”, con il rischio di lasciare nelle mani di una Europa molto poco affidabile la fasi successive e imprevedibili del dopo-Gheddafi. A tutto questo si aggiunge – specie in ambito neocon– la considerazione dei rischi che i sommovimenti “democratici” arabi comportano per l’unica vera democrazia della regione, Israele. Le cui coordinate strategiche e di sicurezza sono state sovvertite dall’uscita di scena di Mubarak che per 30 anni aveva garantito il fronte Sud attraverso il trattato di pace con l’Egitto. E, più in generale, si nutre molta apprensione per un effetto domino regionale che sembra sfuggire alla previsione e al controllo dell’amministrazione Obama e che, alla fine, potrebbe favorire le mire espansionistiche regionali del regime di Teheran.
Conclusioni
Inquadrare l’11 settembre in un tempo più lungo consente, infine, di discernere ciò che di quell’evento drammatico rientra nel regno del contingente da ciò che, invece, è sostanza della politica estera del nuovo secolo, con il quale perciò tutti debbono fare i conti e che ci accompagnerà ancora per molti decenni.
Se si fosse prestato attenzione al percorso che dalla politica estera di Reagan ha portato all’emersione del neo-conservatorism, già a suo tempo si sarebbe potuto evitare di accreditare la falsa contrapposizione tra idealismo e realismo. La posizione di quel gruppo intellettuale che per un tempo assai breve sembrò aver conquistato una posizione egemonica nell’amministrazione repubblicana non è mai stata una versione riveduta e corretta del wilsonismo né tanto meno ha prodotto un decalogo che, come una ricetta medica, abbia la pretesa di lenire ogni ferita. E d’altra parte le critiche che quelle posizioni hanno suscitato non sono classificabili né come una riproposizione adattata ai nuovi tempi della dottrina Monroe né tanto meno come formulazione di una ideologia neo-pacifista. Dopo dieci anni e dopo un’altra crisi, tutto ciò risulta più chiaro: salvo sparuti gruppi di fondamentalisti ed enclaves di ancien régime nessuno più può permettersi di innalzare il vessillo della pace contro la presunta arroganza dei neo-colonialisti.
Quanto da ultimo accaduto, piuttosto, rimanda alle analisi di uno dei più lucidi interpreti di questo nuovo secolo, Samuel Huntington, che fu profeta nell’individuare due costanti che avrebbero scandito il tempo del postcomunismo: da un canto lo scontro di civiltà, che avrebbe riarmato il fondamentalismo islamico ponendo nuovamente al centro della politica la sfida identitaria e riportando alla ribalta il ruolo della religione nello spazio pubblico e persino nella competizione internazionale; dall’altro una tendenza verso l’allargamento dell’area della democrazia nel mondo, che dopo la “prima ondata” successiva all’ultimo conflitto mondiale, la seconda degli anni Settanta durante la quale caddero i regimi autoritari europei, la terza prodottosi in conseguenza dell’89, sta oggi producendo nuove scosse e facendo montare nuove onde [10]. Crisi di civiltà e allargamento della democrazia: due fenomeni apparentemente così contraddittori da elidersi e che, invece, stiamo imparando a comprendere come possano convivere, contaminarsi, celarsi l’uno nell’altro descrivendo, infine, il ritmo drammatico del nuovo secolo. La fine dei regimi nord africani di Mubarak e di Ben Alì, in fondo, ha rappresentato la fine del compromesso possibile e di ogni politica di contenimento: la possibilità di gestire le derive del neo-fondamentalismo attraverso autoritarismi dolci o paternalisti non c’è più; non rappresenta più un riparo di prudenza e di realismo per classi politiche occidentali spaventate dalla prospettiva di nuovi conflitti. Oggi è forse più chiaro perché il Bush apparentemente più prudente è risultato il più deludente e perché anche chi criticò il suo iniziale interventismo sia costretto ad accettare la sfida del mare aperto.
Non casualmente, nel 2009 uno dei giornalisti più attenti alle tematiche neoconservatrici – Brett Stephens – scrisse sul “Wall Street Journal” che “i neocon non sono ancora scomparsi dopo gli anni di Bush perche i tiranni non sono ancora scomparsi”[11]. Era insieme il riconoscimento di una posizione giusta e di un’applicazione sbagliata. Bush aveva lanciato la sua “freedom agenda” sull’onda delle riflessioni neocon, ma non aveva avuto il tempo e il coraggio – secondo molti di loro – di portarla fino infondo.
Se lo avesse fatto molti dei dittatori deposti dalle sommosse popolari in Medio Oriente avrebbero, forse, potuto evitare questa fine concedendo riforme e aperture alle richieste dei loro popoli. E quelli che avessero resistito – i veri “bad guys” –avrebbero meritato in pieno e senza esitazioni l’intervento punitivo dell’America e dei suoi alleati. Oggi in Libia interveniamo coperti da una decisione dell’Onu che ha ascoltato la voce dei ribelli. Ma la politica estera occidentale deve cogliere quest’occasione per trovare la forza di riannodare gli avvenimenti dell’ultimo decennio; di guardare in faccia alle vere sfide del secolo; di secolarizzare e far divenire patrimonio comune quanto di buono si trova nelle riflessioni di un’avanguardia intellettuale che non ha voluto mettere la testa sotto la sabbia dopo l’11 settembre. Solo così l’intervento contro Gheddafi potrà essere la tappa di una lunga e difficile marcia verso la democrazia e non rivelarsi, sul lungo periodo, una insostenibile prepotenza occidentale, in nome di inconfessati interessi, con il fragore delle bombe umanitarie che copre il grido di dolore che ci giunge da Damasco o da Teheran.
Note
[1] G. W. Bush, Dichiarazione all’agenzia di stampa UPI, 17 settembre 2001.
[2] The White House - Office of the Press Secretary, Remarks by the President on Osama Bin Laden, 1° maggio 2011.
[3] G. W. Bush, Speech to a joint session of Congress, 20 settembre 2001.
[4] Ibidem.
[5] R. Reagan, Speech to the House of Commons, 8 giugno 1982.
[6] Ibidem.
[7] The National Security Strategy of the United States of America, White House, 17 settembre 2002.
[8] B. Lewis, Il medio oriente un anno dopo la guerra in Iraq, Lettura annuale Fondazione Magna Carta, 9 marzo 2004.
[9] R. Douthat, A very liberal intervention, «New York Times», 21 marzo 2011.
[10] Cfr. S.P Huntington, The clash of Civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, London 1996 e dello stesso autore, The Third wave: democratization in the late twentieth Century, Unversity of Oklahoma Press, Norman1992.
[11] B. Stephens, The Neocons Make a Comeback, «Wall Street Journal» (online), 29 settembre 2009 (http://online.wsj.com/article/SB1000142405274870447150457443883178997295..., ultima consultazione 29 aprile 2011).
Tratto da11 Settembre. Dieci anni dopo, Ventunesimo Secolo - Rivista di Studi sulle